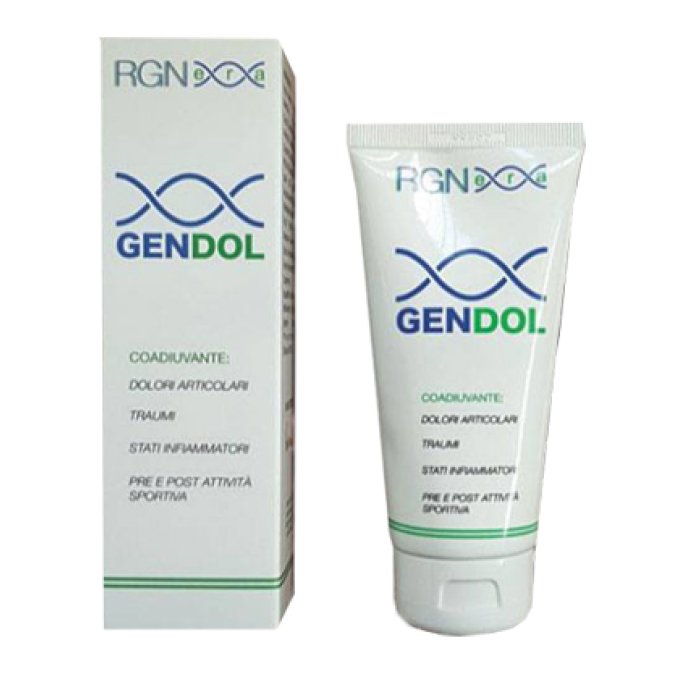Il blog del sorriso

Fibromialgia: sintomi, cause, trattamenti
Fibromialgia sintomi: come si manifesta la patologia
La fibromialgia è una sindrome cronica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, associato a una varietà di sintomi neurologici, cognitivi e sistemici. Il dolore è percepito in almeno quattro regioni corporee su cinque, con una durata di almeno tre mesi. La diagnosi si basa sulla presenza di dolore generalizzato e su scale validate come il Widespread Pain Index (WPI) e il Symptom Severity Score (SSS).
I sintomi principali della fibromialgia comprendono:
- Dolore muscolare cronico, simmetrico e non localizzato, spesso descritto come bruciore, fitte o rigidità.
- Affaticamento persistente, non proporzionale allo sforzo fisico, non alleviato dal riposo.
- Disturbi del sonno, con risvegli frequenti e percezione di sonno non ristoratore.
- Nebbia cognitiva, nota anche come "fibro-fog", con difficoltà di attenzione, memoria e concentrazione.
- Sintomi somatici aggiuntivi, come cefalee, sindrome del colon irritabile, parestesie, vertigini e disturbi urinari.
In alcuni casi si osservano anche allodinia (dolore da stimoli innocui) e iperalgesia (aumento della percezione dolorosa). La sintomatologia può essere intermittente o continua, con fasi di peggioramento o remissione. L'intensità varia da soggetto a soggetto.
Il prossimo paragrafo approfondirà le cause multifattoriali della fibromialgia, con attenzione a genetica, neurofisiologia e fattori ambientali.
Fibromialgia cause: fattori predisponenti e meccanismi patogenetici
La fibromialgia non ha un’eziologia univoca, ma è considerata una sindrome a genesi multifattoriale. I meccanismi coinvolti comprendono alterazioni nella percezione del dolore, predisposizione genetica e influenze psicosociali. La condizione è associata a disfunzioni del sistema nervoso centrale, in particolare nei meccanismi di modulazione nocicettiva.
Le principali cause e fattori di rischio includono:
- Disregolazione neurochimica: alterati livelli di neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e noradrenalina, implicati nella trasmissione del dolore.
- Sensibilizzazione centrale: risposta anomala del sistema nervoso centrale a stimoli sensoriali, con ridotta soglia del dolore.
- Fattori genetici: polimorfismi in geni correlati alla percezione del dolore aumentano la suscettibilità individuale.
- Eventi stressanti: traumi fisici, abusi emotivi, infezioni virali e malattie autoimmuni possono fungere da fattori scatenanti.
- Comorbidità: la fibromialgia è frequentemente associata a sindrome da fatica cronica, depressione, ansia e disturbi del sonno.
L’interazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali porta alla cronicizzazione dei sintomi. La risposta infiammatoria sistemica non è significativa, ma è documentata un’alterazione del sistema di stress neuroendocrino (asse ipotalamo-ipofisi-surrene).
Il paragrafo successivo esaminerà i trattamenti farmacologici e non farmacologici attualmente utilizzati per la gestione della fibromialgia.
Fibromialgia trattamenti: approcci terapeutici efficaci
La gestione della fibromialgia prevede un approccio integrato, orientato alla riduzione dei sintomi e al miglioramento della funzionalità. Non esiste una terapia risolutiva, ma diversi trattamenti consentono il controllo della sintomatologia. Le linee guida internazionali raccomandano l’associazione di interventi farmacologici e non farmacologici personalizzati.
I trattamenti farmacologici approvati includono:
- Antidepressivi triciclici e inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI): come amitriptilina, duloxetina e milnacipran, con efficacia su dolore e sonno.
- Anticonvulsivanti: pregabalin e gabapentin riducono l’iperattività neuronale responsabile del dolore cronico.
- Analgesici: il paracetamolo può essere utilizzato nei casi lievi; i FANS sono generalmente inefficaci nel lungo termine.
- Ipnotici e miorilassanti: solo nei casi selezionati e per brevi periodi, a causa degli effetti collaterali.
Gli interventi non farmacologici comprendono:
- Esercizio fisico: attività aerobica moderata, stretching e potenziamento muscolare migliorano la sintomatologia.
- Psicoterapia: la terapia cognitivo-comportamentale favorisce il coping e riduce l’impatto dello stress.
- Tecniche complementari: yoga, meditazione, biofeedback e agopuntura mostrano benefici in molti pazienti.
- Educazione terapeutica: il paziente deve essere informato sulla natura cronica della patologia e coinvolto attivamente nella gestione.
Il trattamento deve essere continuativo, con monitoraggio periodico degli obiettivi clinici. La risposta varia da soggetto a soggetto e richiede una personalizzazione dell’approccio.