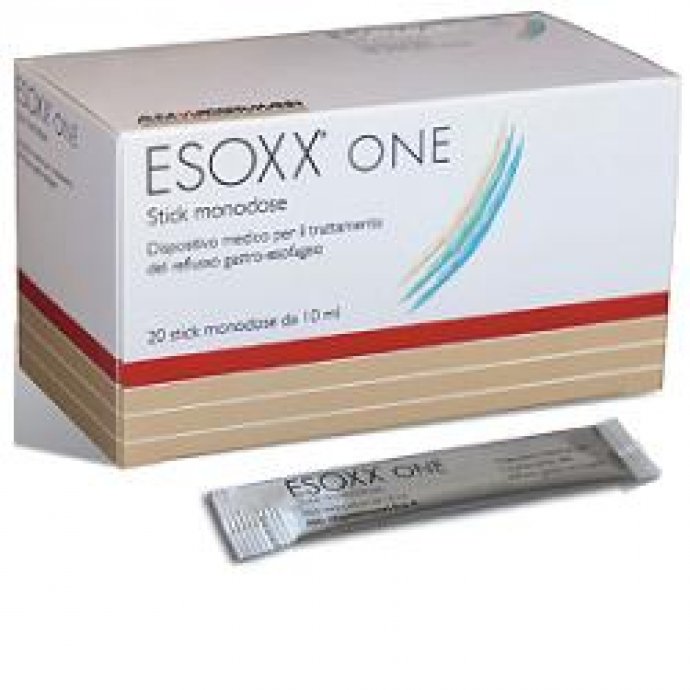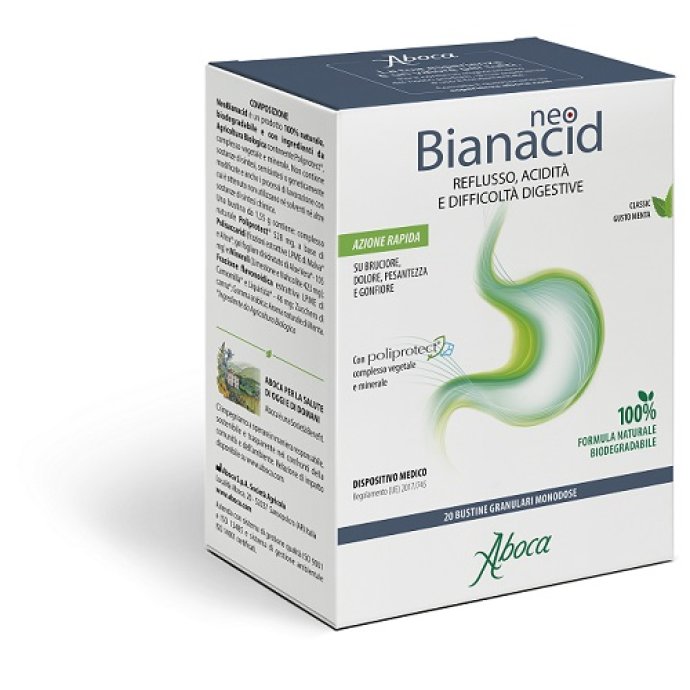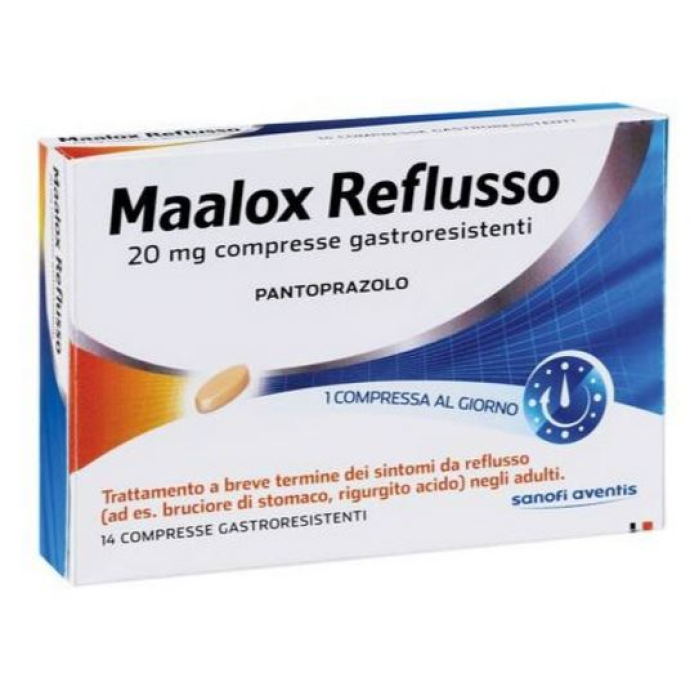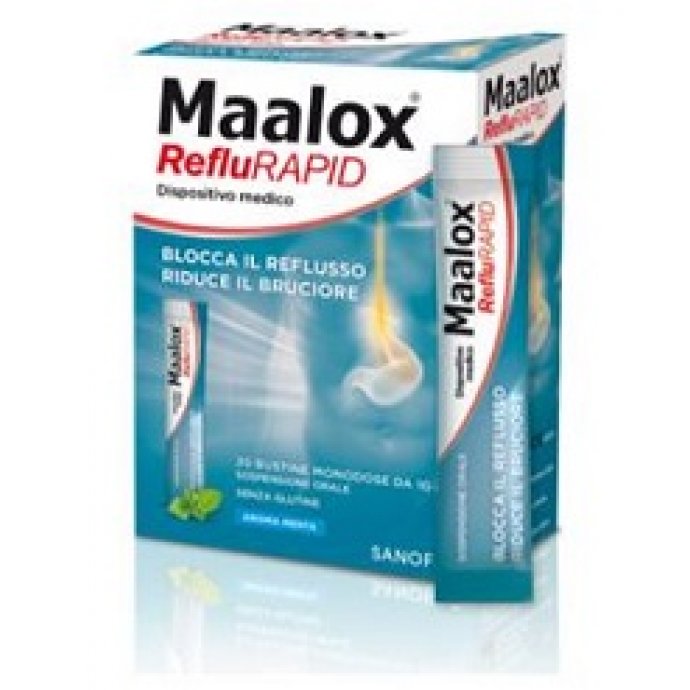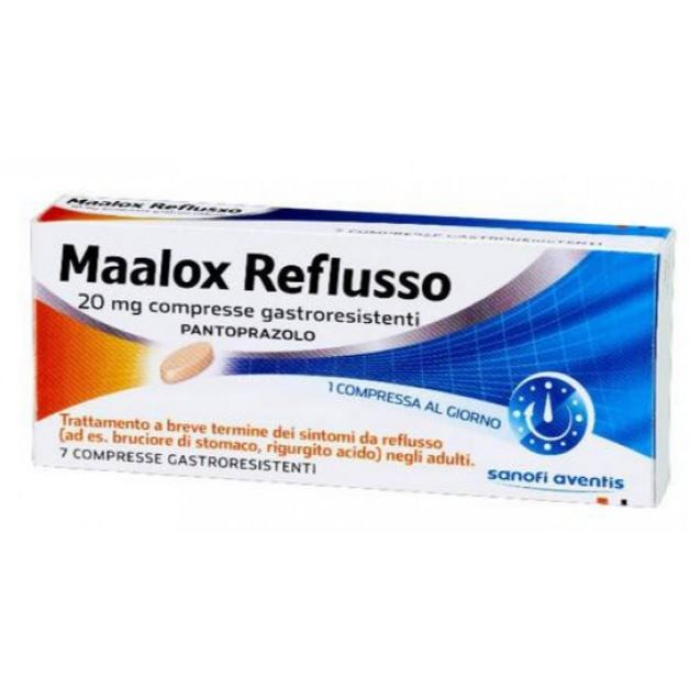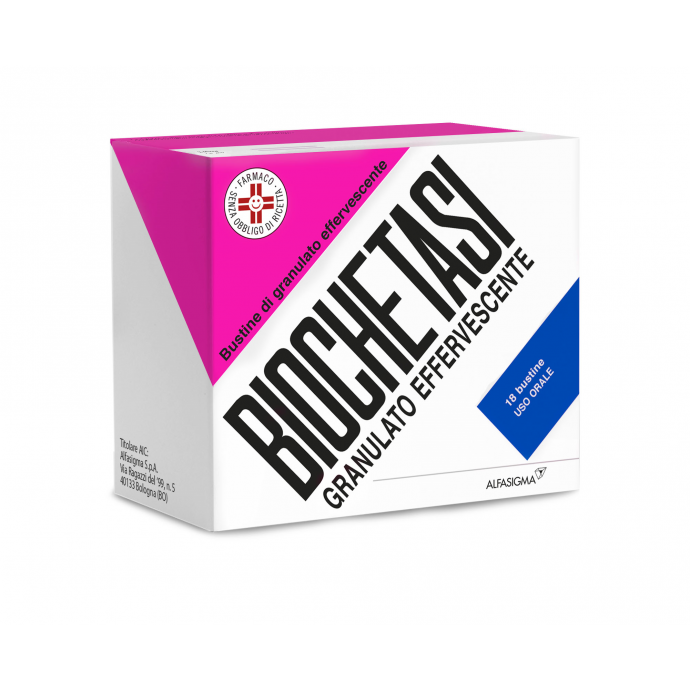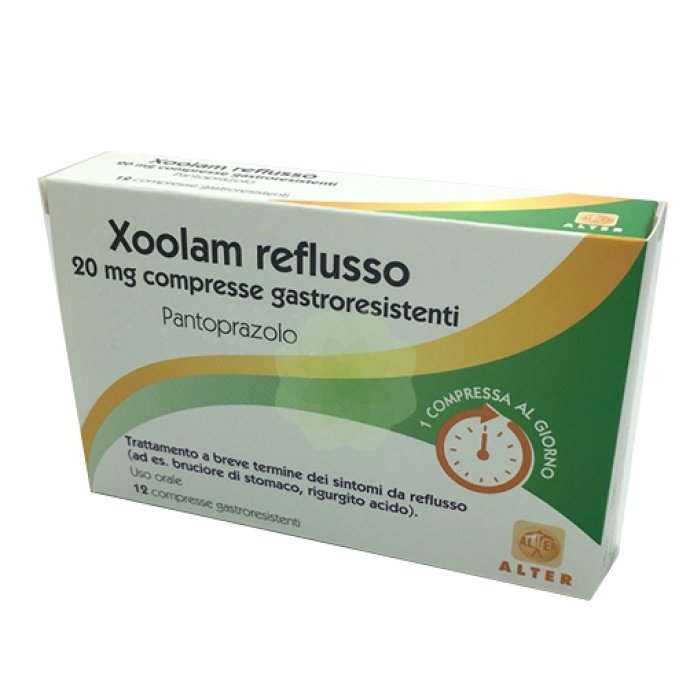Il blog del sorriso

Reflusso gastroesofageo: sintomi, diagnosi, trattamento
Reflusso gastroesofageo e manifestazioni cliniche
Il reflusso gastroesofageo è una condizione in cui il contenuto gastrico risale nell'esofago, causando irritazione e sintomi di varia intensità. La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) si manifesta quando gli episodi di reflusso diventano frequenti e prolungati, superando la soglia di normalità. La presenza continuativa di succhi gastrici in esofago può determinare infiammazione della mucosa esofagea, con rischio di esofagite erosiva.
I sintomi tipici del reflusso gastroesofageo comprendono:
- Pirosi retrosternale, ovvero bruciore dietro lo sterno.
- Rigurgito acido, con percezione di liquido amaro o acido in bocca.
Questi sintomi possono intensificarsi dopo i pasti, in posizione supina o piegandosi in avanti. Sono frequenti nelle ore notturne. I sintomi atipici includono tosse cronica, raucedine, dolore toracico non cardiaco, sensazione di nodo in gola e laringite. In alcuni casi, il reflusso si associa a complicanze come esofagite, stenosi esofagea o esofago di Barrett.
La frequenza dei sintomi, la loro durata e la risposta alla terapia determinano l’inquadramento clinico. La presenza di sintomi notturni o di segni di allarme come disfagia, calo ponderale o anemia richiede approfondimenti diagnostici.
Il prossimo paragrafo descriverà le indagini utili per diagnosticare il reflusso gastroesofageo, distinguendo tra approccio clinico e strumentale.
Diagnosi del reflusso gastroesofageo: strumenti e criteri
La diagnosi di reflusso gastroesofageo si basa principalmente sulla presenza di sintomi tipici e sulla risposta alla terapia antisecretiva. In presenza di pirosi e rigurgito acido, l’inizio di una terapia empirica con inibitori di pompa protonica (IPP) rappresenta un primo criterio diagnostico. In caso di risposta positiva, si conferma l’origine esofagea dei sintomi.
Quando la risposta ai farmaci è assente o i sintomi sono atipici, si ricorre a esami strumentali:
- Gastroscopia (EGDS): consente l’ispezione diretta della mucosa esofagea e la rilevazione di esofagite, ulcere o alterazioni strutturali. Permette anche di eseguire biopsie.
- pH-impedenziometria delle 24 ore: misura il reflusso di materiale acido e non acido nell’esofago. È indicata nei pazienti con sintomi refrattari alla terapia.
- Manometria esofagea: valuta la motilità esofagea e la funzionalità dello sfintere esofageo inferiore. È utile nella preparazione alla pH-metria o in presenza di disfagia.
- Rx con bario: consente la valutazione anatomica del tratto esofago-gastrico, utile per identificare ernie iatali.
L’individuazione tempestiva di eventuali complicanze richiede una diagnosi accurata e un monitoraggio periodico, soprattutto nei pazienti con sintomi recidivanti o persistenti.
Il prossimo paragrafo illustrerà le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento del reflusso gastroesofageo, distinguendo tra interventi dietetico-comportamentali, farmacologici e chirurgici.
Trattamento del reflusso gastroesofageo: dieta, farmaci, chirurgia
Il trattamento del reflusso gastroesofageo si articola in misure non farmacologiche, terapia medica e, nei casi selezionati, trattamento chirurgico. L’obiettivo è ridurre la frequenza e l’intensità degli episodi di reflusso, prevenire le complicanze e migliorare la qualità della vita del paziente.
Interventi sullo stile di vita:
- Perdita di peso nei soggetti in sovrappeso o obesi.
- Elevazione della testata del letto di almeno 15-20 cm.
- Evitare di coricarsi entro tre ore dai pasti.
- Limitare l’assunzione di alimenti che rilassano lo sfintere esofageo inferiore (cioccolato, menta, caffè, alcolici).
- Evitare pasti abbondanti e cibi grassi.
Terapia farmacologica:
- Antiacidi: neutralizzano l’acidità gastrica ma non curano le lesioni esofagee.
- H2-antagonisti: riducono la secrezione acida. L’effetto può attenuarsi nel tempo.
- Inibitori della pompa protonica (IPP): rappresentano la terapia di prima linea nei pazienti con reflusso persistente o con esofagite documentata. Agiscono riducendo la produzione acida in modo prolungato.
- Procinetici: migliorano lo svuotamento gastrico e aumentano il tono dello sfintere esofageo. Sono utili in combinazione con altri farmaci.
Trattamento chirurgico:
La fundoplicatio laparoscopica è indicata nei pazienti che non rispondono alla terapia medica o con ernia iatale voluminosa. La procedura consiste nel rinforzare la giunzione esofago-gastrica per impedire la risalita del contenuto gastrico. In casi selezionati si ricorre a tecniche endoscopiche mininvasive.
Il prossimo paragrafo descriverà le strategie preventive utili a ridurre il rischio di insorgenza del reflusso gastroesofageo o di peggioramento dei sintomi nei soggetti predisposti.
Prevenzione del reflusso gastroesofageo: strategie comportamentali
La prevenzione del reflusso gastroesofageo si basa sull’adozione di abitudini alimentari e comportamentali corrette. Queste misure hanno lo scopo di ridurre la pressione intraddominale, migliorare la funzione dello sfintere esofageo inferiore e limitare la secrezione gastrica acida. Sono efficaci sia nella prevenzione primaria che come supporto alla terapia farmacologica.
Misure alimentari consigliate:
- Evitare cibi reflussogeni come cioccolato, cibi fritti, menta, pomodoro, agrumi, caffè e bevande gassate.
- Prediligere pasti leggeri e frequenti.
- Masticare lentamente e consumare i pasti in posizione seduta.
- Limitare l’assunzione di alcolici.
Comportamenti utili:
- Non coricarsi subito dopo i pasti. Attendere almeno tre ore prima di sdraiarsi.
- Dormire con la testata del letto rialzata.
- Smettere di fumare, in quanto la nicotina riduce il tono dello sfintere esofageo inferiore.
- Mantenere un peso corporeo adeguato, con particolare attenzione alla circonferenza addominale.
L’efficacia delle misure preventive aumenta se integrate in un piano terapeutico individuale. La gestione a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo richiede continuità, monitoraggio clinico e, se necessario, adattamento della terapia.