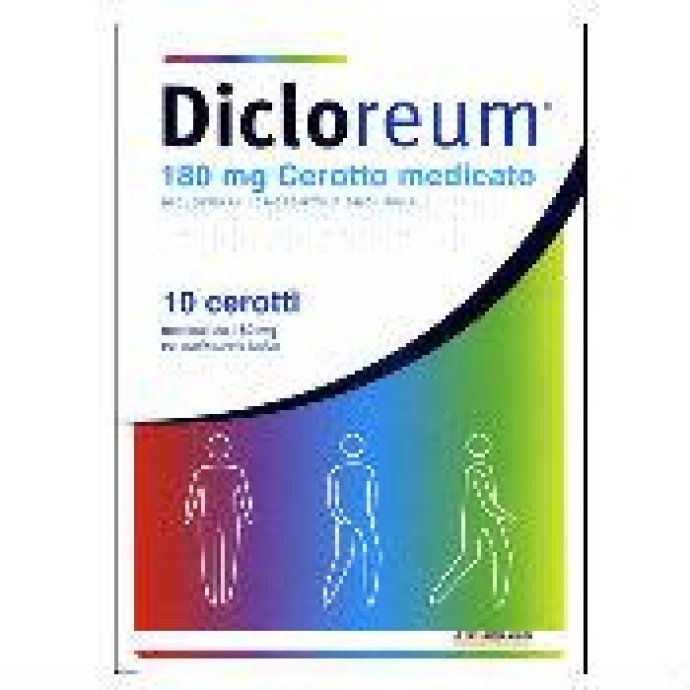Il blog del sorriso

Malattie reumatiche: sintomi, diagnosi e trattamenti
Quali sintomi indicano la presenza di malattie reumatiche
Le malattie reumatiche si manifestano principalmente con dolore articolare, rigidità, gonfiore e riduzione della mobilità articolare. Questi sintomi sono spesso accompagnati da affaticamento generalizzato e sensazione di malessere, anche in assenza di febbre o infezione acuta. Nelle forme infiammatorie croniche, il dolore è continuo e peggiora durante il riposo notturno. La rigidità mattutina può durare più di trenta minuti e rappresenta un segno distintivo delle artriti infiammatorie rispetto alle forme degenerative.
I sintomi possono colpire anche altri distretti corporei oltre alle articolazioni. Alcune patologie reumatologiche coinvolgono tendini, legamenti, muscoli, cute e organi interni come polmoni, cuore e reni. In caso di connettiviti sistemiche, si osservano sintomi sistemici come febbre, eruzioni cutanee, secchezza oculare e orale, difficoltà respiratorie e disturbi renali. Altri sintomi comuni includono il formicolio alle estremità, la perdita di forza muscolare e la fotosensibilità cutanea.
La variabilità clinica rende necessario il riconoscimento precoce dei sintomi, anche lievi, per avviare tempestivamente un percorso diagnostico e terapeutico appropriato. La persistenza di dolore articolare per più di sei settimane, specie se bilaterale e associato a tumefazione, deve essere considerata un criterio di sospetto per una patologia reumatica.
Nel prossimo paragrafo verranno illustrate le principali metodologie diagnostiche utilizzate per identificare con precisione la presenza di una malattia reumatica e per differenziarne le varie forme cliniche.
Come viene diagnosticata una malattia reumatica
La diagnosi delle malattie reumatiche si basa sulla valutazione clinica da parte di uno specialista reumatologo, integrata da esami di laboratorio e diagnostica per immagini. La visita reumatologica include l’anamnesi dettagliata, la valutazione dei sintomi riferiti dal paziente e l’esame obiettivo articolare e sistemico. L’anamnesi considera familiarità per patologie autoimmuni, presenza di malattie associate e fattori di rischio ambientali.
Gli esami del sangue consentono di individuare marcatori infiammatori come VES (velocità di eritrosedimentazione) e PCR (proteina C reattiva). Possono essere prescritti anche autoanticorpi specifici, tra cui il fattore reumatoide (FR), gli anticorpi anti-CCP, gli ANA (anticorpi antinucleo) e gli ENA (anticorpi estratti nucleari), utili per differenziare tra le diverse connettiviti sistemiche. In presenza di sintomi articolari acuti, può essere esaminato il liquido sinoviale attraverso artrocentesi.
Gli esami strumentali comprendono radiografie, ecografie articolari, risonanza magnetica e TAC. L’ecografia muscoloscheletrica con Power Doppler permette di visualizzare infiammazioni articolari precoci e di distinguere tra patologie degenerative e infiammatorie. La capillaroscopia è utile nella diagnosi di sclerodermia e di altre connettiviti con coinvolgimento microvascolare.
Nel paragrafo successivo verranno analizzate le principali categorie di malattie reumatiche, suddivise per origine patogenetica e tessuti colpiti, con esempi clinici rilevanti.
Quali tipi di malattie reumatiche esistono e come si classificano
Le malattie reumatiche sono classificate in quattro categorie principali: infiammatorie, degenerative, autoimmuni sistemiche e dismetaboliche. Le forme infiammatorie includono l’artrite reumatoide, la spondilite anchilosante e le spondiloartriti, caratterizzate da infiammazione cronica delle articolazioni e della colonna vertebrale. Le forme degenerative comprendono l’artrosi, dove si osserva un deterioramento progressivo della cartilagine articolare senza componente autoimmune.
Le malattie autoimmuni sistemiche, o connettiviti, coinvolgono più organi e tessuti e includono lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica e sindrome di Sjögren. Queste patologie presentano una risposta immunitaria alterata che genera infiammazione diffusa e persistente. Le forme dismetaboliche, come la gotta, sono causate da accumulo di metaboliti come l’acido urico che si deposita nelle articolazioni sotto forma di cristalli, provocando infiammazione e dolore acuto.
Tra le forme extra-articolari, la fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscolare diffuso e ipersensibilità al tatto, senza evidenza di infiammazione o danno articolare. L’osteoporosi, invece, è una patologia ossea caratterizzata da ridotta densità minerale e aumentato rischio di fratture, frequentemente associata ad altre malattie reumatologiche o all’uso cronico di corticosteroidi.
Nel paragrafo seguente verranno descritte le cause e i fattori di rischio che favoriscono l’insorgenza delle diverse tipologie di malattie reumatiche, con riferimento ai meccanismi patogenetici noti.
Quali sono le cause e i fattori di rischio delle malattie reumatiche
Le malattie reumatiche riconoscono una genesi multifattoriale che include predisposizione genetica, fattori ambientali e alterazioni del sistema immunitario. La presenza di mutazioni o polimorfismi in geni associati alla regolazione immunitaria può aumentare il rischio di sviluppare malattie autoimmuni. Tuttavia, la predisposizione genetica da sola non è sufficiente all’esordio clinico.
Tra i principali fattori ambientali implicati figurano infezioni virali o batteriche, fumo di sigaretta, stress cronico, esposizione a sostanze tossiche, sedentarietà e sovrappeso. Il virus di Epstein-Barr è stato associato all’insorgenza del lupus eritematoso sistemico. La disbiosi intestinale è ritenuta un possibile elemento scatenante in alcune spondiloartriti.
Gli ormoni sessuali influenzano l’incidenza delle malattie reumatologiche. Le donne presentano una maggiore prevalenza di connettiviti sistemiche, probabilmente a causa degli effetti immunomodulanti degli estrogeni. Alcune patologie insorgono in età pediatrica, mentre altre, come l’osteoporosi e l’artrosi, aumentano con l’età avanzata.
Nel prossimo paragrafo verranno descritti i principali trattamenti farmacologici e non farmacologici per la gestione delle malattie reumatiche, con riferimento alle linee guida terapeutiche aggiornate.
Come vengono trattate le malattie reumatiche
Il trattamento delle malattie reumatiche ha l’obiettivo di ridurre l’infiammazione, alleviare i sintomi, rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita. La terapia è personalizzata in base alla tipologia di patologia, allo stadio clinico e alla risposta individuale. I farmaci più utilizzati includono FANS, corticosteroidi, DMARDs sintetici e farmaci biologici.
I FANS riducono dolore e infiammazione nelle fasi attive della malattia. I corticosteroidi sono impiegati nei casi di riacutizzazione o in presenza di coinvolgimento sistemico. I DMARDs (Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs), come metotrexato o sulfasalazina, modificano l’andamento della patologia. I farmaci biologici, come anti-TNF o anti-IL-6, sono riservati ai casi refrattari o severi e agiscono su specifici bersagli molecolari dell’infiammazione.
Approfondisci anche tutto sul Voltaren
La gestione terapeutica prevede anche trattamenti non farmacologici, come fisioterapia, esercizio fisico adattato, dieta equilibrata e supporto psicologico. In alcuni casi è necessario l’intervento chirurgico, come la sostituzione articolare, per ripristinare la funzionalità articolare compromessa. Il monitoraggio periodico consente di calibrare la terapia in funzione dell’attività di malattia e degli effetti collaterali.
Nel paragrafo successivo verranno forniti esempi di strategie preventive per ridurre il rischio di complicanze nelle persone con malattie reumatiche e per migliorare l’autogestione quotidiana della patologia.
Quali misure preventive adottare contro le complicanze delle malattie reumatiche
La prevenzione delle complicanze nelle malattie reumatiche si basa sull’adozione di uno stile di vita sano e sull’aderenza al trattamento prescritto. Mantenere un peso corporeo adeguato riduce il carico sulle articolazioni e limita il rischio di artrosi o aggravamento della malattia. L’attività fisica regolare, supervisionata da professionisti, migliora la mobilità articolare, la forza muscolare e la funzione cardiovascolare.
Una dieta equilibrata, ricca di acidi grassi omega-3, fibre e antiossidanti, contribuisce a modulare l’infiammazione sistemica. È raccomandata l’abolizione del fumo e la limitazione dell’alcol. L’esposizione solare controllata può favorire la sintesi di vitamina D, importante per la salute ossea e immunitaria. I pazienti con osteoporosi devono adottare misure per prevenire le cadute, come l’eliminazione di ostacoli domestici e l’installazione di corrimano.
La vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica è indicata nei soggetti immunodepressi o trattati con farmaci biologici o corticosteroidi. L’automonitoraggio dei sintomi e il coinvolgimento attivo del paziente nel percorso terapeutico favoriscono il controllo a lungo termine della malattia. Il supporto di un team multidisciplinare, che includa reumatologo, fisioterapista, nutrizionista e psicologo, ottimizza la gestione integrata della condizione.